Quanto conta sottoporsi allo sguardo degli altri quando si lavora a un progetto fotografico? Al Baretto, dilettanti come siamo, ne abbiamo fatto una pratica costante cercando di imparare dagli errori e da gente più brava di noi.
Le fotografie infatti, a uno stadio iniziale, possono essere l’estensione di una postura corporea e mentale di cui non ci accorgiamo, che diventa in automatico scelta di soggetti, distanze, composizioni, frutto di un approccio reattivo o solamente espressivo. Un atteggiamento inconsapevole che ruota intorno a un nucleo ancora confuso e tiene assieme molti piani: il corpo gestuale e il suo modo di stare nello spazio, i pensieri, le emozioni e le loro “traduzioni” informazionali o simboliche in forme visive, l’eco di lavori altrui e degli studi fatti su ciò che ci circonda o su di sé, e ancora le mode, i cliché visivi, e soprattutto la mediazione della macchina e la forma significante prodotta dalla sua tecnologia, mai innocente o neutrale.
Ma, questo è il punto, non è possibile a nessuno guardarsi da fuori per cogliere al volo la propria postura, nemmeno quando si presenta in ritagli, nei prelievi incorniciati e allusivi della fotografia: perché diventi “sguardo” (inteso non come prodotto isterico e autoindulgente di un presunto “Autore”, ma come relazione consapevole e dotata di senso tra mondo, macchina e persona) è necessario riflettere quella postura fuori di sé e attendere il rimando di altri. Una fase dello specchio, insomma.
Quel che abbiamo capito è che lavorare per un certo tempo su un soggetto, magari non del tutto chiaro, non porta a molto se ad un certo punto non si sente il bisogno di stampare il materiale, di stenderlo sul tavolo, di guardarlo e farlo vedere ai propri pari o, se si ha fortuna, a qualcuno che ne sa di più. Prima da soli poi assieme ad altri, osservare con calma serve a individuare le ricorrenze, le differenze, a ragionare sul vero nucleo del lavoro.
Al Baretto poi stiamo scoprendo che, oltre al ragionamento e al confronto visuale, si possono sperimentare in modo “selvaggio” altri strumenti – magari importati da altre discipline, come ad esempio l’utilizzo proiettivo delle immagini nelle psicoterapie, a lungo studiato da una pioniera come Judy Weiser – per “non ragionare”, lasciando che quel nucleo si distingua facendosi strada tra i contenuti, i temi, le proiezioni emotive e così via.
La fotografia non è lo scatto ma è un lavoro che vuole calma e tempo. Raccogliere sul campo, selezionare, stampare, guardare assieme, enucleare, tornare a raccogliere, ristampare, guardare di nuovo, scartare e scartare (l’operazione più importante di tutte). Infine, in un processo che può essere anche pieno di ripensamenti e false piste, individuare la “sequenza”, cioè la modalità di fruizione che coordinerà quel nucleo tra un inizio e una fine.
Questo processo di “costruzione dello sguardo” è alla base anche della produzione del libro fotografico, uno dei mezzi più fortunati, flessibili e interessanti che la fotografia abbia mai trovato lungo il suo cammino. Al Baretto ci stiamo preparando ad affrontare questo tema nei prossimi mesi, in un ciclo di incontri che stiamo organizzando assieme ad alcuni degli editori indipendenti di fotografia più interessanti del panorama italiano: Urbanautica, Witty Kiwi, Rorhof, Skinnerboox, assieme ai loro autori e ad altri che si stanno aggiungendo, con il supporto fondamentale di Libreria Verso di Milano e di Matteo Balduzzi del Museo di Fotografia Contemporanea. A breve arriveranno notizie, state in campana.
E siccome non si impara se non facendo, da tempo usiamo i nostri lavori come banco di prova per capirne le possibilità, partendo dalle basi. Quindi, prima di avere a che fare con i professionisti del libro fotografico, potete godervi gli esercizi del Baretto:
nel reparto Produzioni, in pdf o stampabili a richiesta.
Immagine: Elina Brotherus, Caspar David Friedrich, elaborazione: Baretto Beltrade.



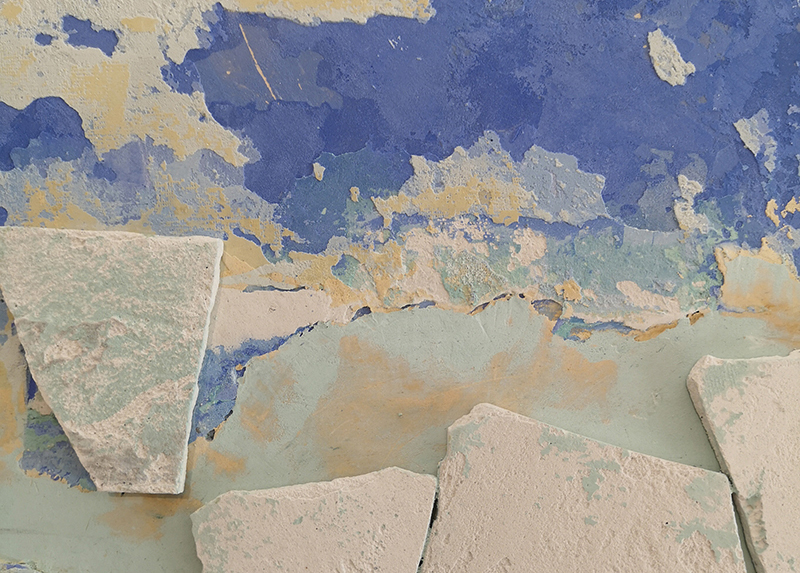


Scrivi un commento