Questa è una famosa fotografia di Jeff Wall del 1992 intitolata «Soldati morti parlano. Visione dopo un’imboscata a una pattuglia dell’Armata Rossa vicino a Moqor, Afghanistan, inverno 1986».
Così ne parla Susan Sontag nel libro «Davanti al dolore degli altri» (Mondadori), in cui si occupa dell’effetto esercitato sulla coscienza degli individui delle fotografie che rappresentano situazioni di dolore e di guerra.
«
Tra le singole immagini contro la guerra, l’enorme fotografia realizzata da Jeff Wall nel 1992 e intitolata «Dead Troops Talk (A Vision After an Ambush of a Red Army Patrol Near Moqor, Afghanistan, Winter 1986» (Soldati morti parlano. Visione dopo un’imboscata a una pattuglia dell’Armata Rossa vicino a Moqor, Afghanistan, inverno 1986) mi sembra esemplare per forza e profondità. Antitesi di un documento, l’immagine, un cibachrome alto due metri e mezzo e largo più di quattro, montato su un cassonetto luminoso, mostra delle figure in posa in un paesaggio, il disastrato versante di una collina, ricostruito nello studio dell’artista. Wall, che è canadese, non è mai stato in Afghanistan. L’imboscata è un evento immaginario sullo sfondo di una barbara guerra a cui i mezzi di informazione hanno dato estremo risalto.
Wall si è prefisso il compito di immaginare l’orrore della guerra (sostiene di essersi ispirato a Goya) al modo della pittura storica ottocentesca e delle altre forme di spettacolarizzazione della storia apparse tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, poco prima dell’invenzione della macchina fotografica: i tableaux vivants, i gabinetti delle cere, i diorami e i panorami che davano al passato, specie a quello più vicino, una sorprendente e inquietante apparenza di realtà.
I personaggi della visionaria opera fotografica di Wall sono «realistici», ma naturalmente l’immagine non lo è. I soldati morti non parlano. In questo caso sì.
Tredici soldati russi in pesanti uniformi invernali e alti stivali sono sparpagliati su un pendio crivellato, chiazzato di sangue e coperto di sassi e di rifiuti della guerra: metallo accartocciato, uno stivale in cui resta la parte inferiore di una gamba… La scena potrebbe essere una versione riveduta della fine di J’accuse di Abel Gance, quando i soldati caduti nella Prima guerra mondiale resuscitano dalla tomba, ma queste reclute russe, massacrate nel corso dell’ultima folle guerra coloniale mossa dall’Unione Sovietica, non sono mai state sepolte. Alcune di loro indossano ancora l’elmetto. La testa di un personaggio inginocchiato schiuma di rossa materia cerebrale. L’atmosfera è calda, conviviale, cameratesca. Alcuni sono stravaccati, appoggiati su un gomito, o siedono a chiacchierare, con il cranio scoperchiato e le mani distrutte in bella mostra. Un uomo si china su un altro disteso su di un fianco e come addormentato, forse per incoraggiarlo a mettersi seduto. Tre uomini fanno i buffoni: il primo, con un’enorme ferita sullo stomaco, è a cavalcioni del secondo che giace prono e ride di un terzo che, inginocchiato, gli sventola scherzosamente in faccia un lembo di carne. Un soldato con l’elmetto in testa ma privo di gambe si volta, con un vispo sorriso, in direzione di un commilitone che si trova a una certa distanza. Sotto di lui ci sono altri due uomini che non danno l’impressione di poter resuscitare e giacciono supini, con la testa insanguinata riversa sul pendio pietroso.
Assorbiti dall’immagine, così accusatoria, potremmo immaginare che i soldati si voltino e comincino a parlarci. E invece no, nessuno di essi guarda verso di noi. Non c’è alcuna minaccia di protesta. Non stanno per urlarci di metter fine a quell’abominio che è la guerra. Non sono tornati in vita, barcollando, per denunciare i guerrafondai che li hanno mandati a uccidere e a essere uccisi. E non sono neppure raffigurati in modo tale da suscitare terrore negli altri: tra loro (all’estrema sinistra) siede, inosservato, un saccheggiatore afgano vestito di bianco, tutto preso a rovistare nello zaino di qualcuno, mentre più in alto fanno il loro ingresso (nell’angolo superiore destro dell’immagi- ne), due afgani che sbucano dal sentiero lungo il pendio, forse anch’essi soldati che, come si deduce dai kalashnikov accatastati ai loro piedi, hanno già spogliato delle armi i caduti.
Questi morti mostrano un supremo disinteresse per i vivi: per quelli che hanno tolto loro la vita, per i testimoni – e per noi. Perché mai dovrebbero cercare il nostro sguardo? Che cosa avrebbero da dirci? «Noi» – e questo «noi» include tutti quelli che non hanno mai vissuto nulla di simile a ciò che loro hanno affrontato – non capiamo. Non ce la facciamo. Non riusciamo a immaginare davvero come è stato. Non possiamo immaginare quanto è terribile e terrificante la guerra; e quanto normale diventa. Non capiamo, non immaginiamo. È questo ciò che pensano con convinzione tutti i soldati, e tutti i giornalisti, gli operatori umanitari, gli osservatori indipendenti che si sono ripetutamente esposti al fuoco e hanno avuto la fortuna di eludere la morte che ha falciato chi stava loro vicino. E hanno ragione.
»
Susan Sontag.



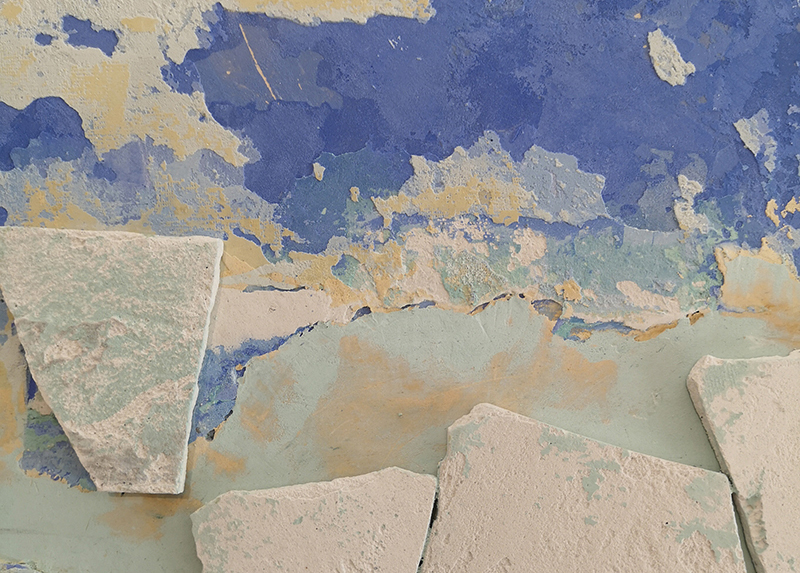


Scrivi un commento